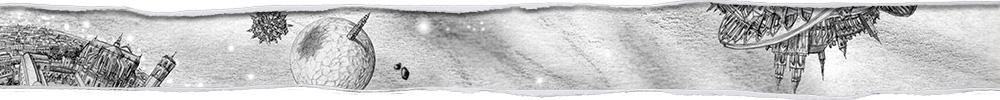“La terra è un paradiso. L’inferno è non accorgersene”
Jorge Luis Borges
Ci sono cose che non dimentichi mai, per quanto il tempo e le sue intemperie possano provare a cancellare parti della tua memoria. Nella Manchester degli anni 50, in preda al singolare incrocio di sentimenti tra smarrimento post-imperiale e “spirito di Dunkirk”, la gente provava a rimettersi in piedi in un processo di ricostruzione tra i più difficili mai affrontati dalla storia dell’Isola. Si era vinta, dopo aver rischiato seriamente di perderla, una guerra che era stata causa di una forte perdita di senso dell’orientamento di noi inglesi. Non era agevole capire cosa saremmo diventati dal 1945 in poi. Mio padre Bob era tornato a Manchester dopo essere sopravvissuto su vari fronti a sei lunghi anni di guerra e si era messo a distribuire film nelle sale cinematografiche da lui gestite. Le occasioni di svago diventarono presto l’occasione per riappropriarsi della normalità; e lo svago per eccellenza, nella mia città, è stato e sempre sarà il calcio. Il Maine Road (casa del City) e l’Old Trafford (casa dello United) vengono presi d’assalto da tifosi innamorati, vogliosi di tornare a vedere tutte le magie possibili da immaginare con un pallone tra i piedi. Sono gli anni in cui un giornalista del “Manchester Evening News”, Frank Nicklin, definisce “Busby Babes” (ragazzi di Busby) una nidiata di giovani ragazzi di talento destinati a vincere due campionati di “First Division” di seguito. Ragazzi cresciuti nelle giovanili dello United, sotto l’amorevole guida di Jimmy Murphy. Erano ragazzi che presto sarebbero diventati giovani uomini celebri, ma che avevano conservato i piedi ben piantati per terra, aiutati dall’istinto degli umili. Molti di loro per lungo tempo continueranno a dividersi tra il calcio e l’apprendimento di un mestiere. Duncan Edwards, il grande Duncan Edwards, si preoccupò con autentica dedizione di imparare il mestiere di carpentiere. Era un autentico figlio delle West Midlands dal forte accento “Black Country”, che ricordava a tutti come nella zona in cui era nato e cresciuto ci fosse un forte tasso d’inquinamento, a causa dell’elevato uso di carbone usato nelle fabbriche siderurgiche, che ricopriva tutto il territorio di una spessa coltre di fuliggine nera (da qui il nome “Black Country”). Uno così non poteva non essere amato alla follia da gente che di giorno operava nelle difficili condizioni di lavoro delle fabbriche tessili, un settore colpito da continui e terribili alti e bassi, causa di periodiche sacche di disoccupazione e lavoro sottopagato. Ma i mancuniani, vedendo giocare il sabato questo ragazzone delle West Midlands, dimenticavano qualsiasi cosa di negativo fosse presente nelle loro vite. Il calcio, dopo tanto dolore e dopo tante perdite, tornava a rappresentare un’esistenza non fatta solo di aspettative negative, ma anche di gioie indescrivibili e inaspettate. Lo scorrere della palla sul prato verde tornava a parlare finalmente di vita, con i suoi rovesci e i suoi successi. E la guerra, con la sua sospensione dell’umanità, cominciava a essere un ricordo sempre più lontano. Bambino, guardavo rapito le gesta del mio United nel rettangolo del Old Trafford, ma ero ancora più incantato a vedere gli sguardi di uomini e donne convinti di assistere alla rappresentazione più bella del mondo. Lo stadio ha il dono di farci ritornare bambini, in quell’età dove l’unica ansia è quella di scoprire e di godere delle cose del mondo. Ecco perché da una cosa semplice e banale come un pallone passato da ventidue uomini, a volte è facile passare da una gioia al dramma e viceversa. Il calcio ha il potere di farci passare “l’inverno del nostro scontento”, ritrovandoci di fronte a storie inaspettate. Pierre Ndaye Mulamba era una giocatore dello Zaire (oggi Congo), forse uno degli attaccanti africani più forti di sempre. Provate a immaginare un feroce dittatore (Mobutu), una vetrina come i mondiali di calcio del 1974 e l’obbligo per una squadra, lo Zaire, di non prendere più di due gol dal Brasile di Rivelino. Pena un triste destino per i giocatori e le loro famiglie. Il Brasile, vincendo tre a zero quella partita, segnò tragicamente il destino di quei giocatori africani, e in particolare quello di Pierre Ndaye. Mobutu non dimentica la triste figura che quei mondiali tedeschi fanno fare al suo potere e dopo poco tempo ordina ai suoi soldati l’eliminazione di questo giocatore scomodo, perché amato dalla gente. Ndaye viene buttato da un ponte e creduto morto, ma in realtà è solo gravemente ferito. Dei bambini, suoi grandissimi tifosi, lo salvano e riesce a fuggire in Sud Africa, riparato nelle townships e dove per vivere fa il custode abusivo di parcheggi. Praticamente è nella condizione di un mendicante. La Fifa, dopo avergli dedicato un minuto di silenzio perché creduto morto, venuta a conoscenza delle sue condizioni di povertà, cerca di rimediare alla gaffe disponendo di donargli settemila dollari (Blatter si era veramente sprecato…). Questi soldi non arriveranno mai a destinazione. Ma il calcio lo si ama perché è una vera metafora della vita; e nella vita ogni caduta, quasi sempre, ha una possibilità di resurrezione. E allora capita di incontrare una donna, Nzwaki Qeqe, occupata nell’ambito della protezione dei rifugiati, che non solo sposa l’ex calciatore sfortunato ma, scoperta la sua condizione di leggenda dello sport africano, lo coinvolge a occuparsi all’avviamento al calcio dei giovani rifugiati. Dopo anni di patimenti e tribolazioni, ecco il pallone ritornare nelle mani di Pierre Ndaye. Il calcio è resurrezione e, a volte, anche occasione di esporsi per contribuire a dare giustizia. Ci sono giocatori simbolo, che non dimenticano di essere espressione di una comunità. Quando fu il momento non lo ha dimenticato Carlos Caszely, celebre attaccante del Colo Colo e della nazionale cilena degli anni 70, che nel referendum pro o contro Pinochet indetto nel 1988 in un Cile dal più alto tenore di vita del Sud America, trova il coraggio e la forza di schierarsi contro il dittatore cileno. La sua presa di posizione pubblica contribuì non poco alla sorprendente affermazione della posizione referendaria contro Pinochet. Ecco, ancora una volta, le storie di calciatori che vanno a intersecarsi con quelle dei tifosi, in nome di quella gioia ripetuta in perpetuo per infiniti e interminabili novanta minuti. La maglia che ti si attacca addosso, mentre ti racconta gli sforzi e i sogni di innumerevoli generazioni. Valori che saltano fuori mentre il pallone sta rotolando lentamente dentro la rete, e in quei secondi interminabili c’è tutta la speranza del mondo. Non ci sono più i manager, i procuratori, i soldi, gli sponsor, il potere, le invidie, gli egoismi: solo una speranza che rotola davanti ai nostri occhi. Per me è così da quando bambino, negli anni 50, cominciai a capire le ragioni e le geometrie sentimentali di questo fantastico gioco. Una rilevazione del F.I.L. (Felicità Interna Lorda) ha recentemente stabilito che gli italiani sono al di sotto della media OCSE per soddisfazione di vita. “Sono scontenti e hanno reazioni estreme di fronte a un sorpasso, a uno sgarbo, a un conflitto sentimentale, a un contenzioso di condominio. Sotto l’apparente normalità scorrono il rancore, la rabbia, la frustrazione. Nervosi, schizzati, intolleranti: così percepiscono il prossimo e viceversa”. Forse così si spiegano anche alcune reazioni allo stadio da parte di tifosi o sedicenti tali, vittime di una infelicità interiore a impedire di godere di un amore che pure, in quanto spettatori paganti, è stato dichiarato al momento dell’acquisto del biglietto della partita. “Ho commesso il peggior peccato che uno possa commettere: non sono stato felice.”, ha scritto Borges in uno dei suoi passaggi mentali intrisi di verità rilevate. Ho letto questa frase ormai diventato adulto e ancora attonito dal dolore dell’incidente aereo di Monaco, che in pochi secondi consegnò al mio dolore di bambino la perdita dei Busby Babes (zio e padrino dell’autore di questo editoriale – n.d.r.). In quella frase di Borges ho riscoperto il senso del mio amore per il calcio e delle sue occasioni di continue resurrezioni. E allora, improvvisamente, ho afferrato il senso delle parole con cui Stanley Matthews volle ricordare la perdita di Duncan Edwards, l’eroe della mia infanzia: “Vederlo giocare è stato come vedere una roccia in mezzo al mare in tempesta”. In quel momento ho accettato la mia perdita, e in quel mare in tempesta ho ritrovato il mio United e la mia felicità. Quanto amo questo gioco…
di Anthony Weatherill
(ha collaborato Carmelo Pennisi)
Sono gli anni in cui un giornalista del “Manchester Evening News”, Frank Nicklin, definisce “Busby Babes” (ragazzi di Busby) una nidiata di giovani ragazzi di talento destinati a vincere due campionati di “First Division” di seguito. Ragazzi cresciuti nelle giovanili dello United, sotto l’amorevole guida di Jimmy Murphy. (da PER AMORE DEL GIOCO – Editoriale di Anthony Weatherill)